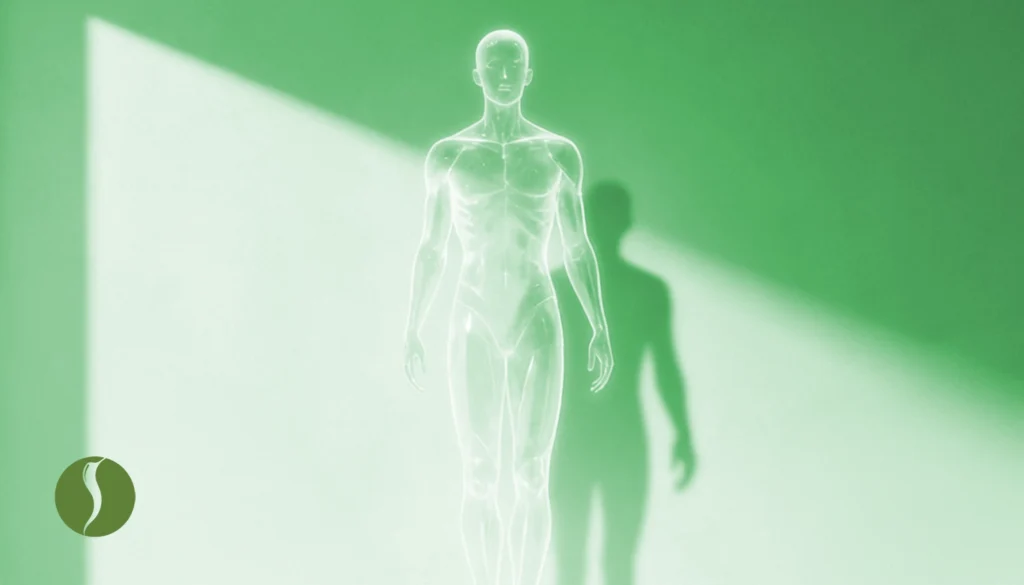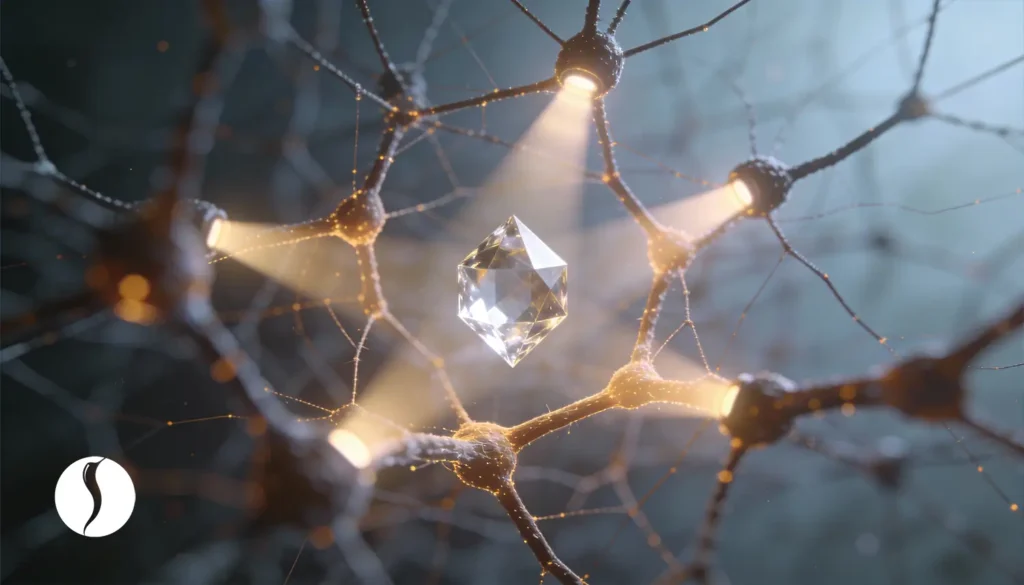Ma cosa accade realmente, dentro di noi, quando lasciamo un dito nella porta o quando ci bruciamo, per esempio, con una pentola bollente?
Di sicuro, sperimentiamo una serie di reazioni riflesse come l’accelerazione della frequenza cardiaca e respiratoria, la dilatazione delle pupille e la retrazione dell’arto, comportamenti che testimoniano il dolore accusato.
E cosa accade invece a livello del sistema nervoso? Si attivano le terminazioni site in tutti gli organi (cute, visceri, muscoli, periostio, ecc…), terminazioni che avvertendo lo stimolo come doloroso e nocivo vengono definite recettori dolorifici o nocicettori.
Segue la trasmissione, verso il midollo spinale e attraverso le fibre di nervi periferici, plessi e radici, delle informazioni raccolte dai recettori in periferia.
Dopo essere state filtrate una prima volta, le informazioni dolorifiche vengono quindi trasferite verso i centri e le aree cerebrali superiori dove si tengono i processi che ci fanno prendere coscienza del fatto che sta succedendo qualcosa di nocivo e dove le informazioni vengono elaborate fino a farci percepire la caratteristica sensazione sgradevole associata al dolore.
Nel 2018, la ormai riconosciuta definizione fornita dall’AISD viene tuttavia rimaneggiata perché possa descrivere l’esperienza dolore in modo ancora più preciso dal punto di vista biologico, psicologico e sociale evidenziando così come la stessa possa inficiare la funzionalità e il benessere psicologico e sociale1.
Detto ciò, aggiungiamo un secondo tassello e classifichiamo il dolore in acuto, cronico e persistente in base alla sua durata, mentre in rapporto all’origine della lesione che determina lo stimolo algico distinguiamo forme di dolore idiopatiche, nocicettive e neuropatiche2,3.
Che cos’è il dolore neuropatico
Il dolore neuropatico può essere definito come la sensazione dolorosa causata da una lesione o malattia del sistema nervoso somatosensoriale deputato alla trasmissione delle informazioni provenienti dall’esterno (olfatto, vista, udito) e dall’interno (tessuti, organi)3,4.
Il dolore neuropatico può essere, a sua volta, classificato in rapporto a3:
- sede della lesione o della malattia (centrale o periferico);
- eziologia (origini traumatiche, ischemiche, emoraggiche, neoplastiche, metaboliche);
- sintomi e segni (deficit sensoriali, ipersensibilità, qualità del dolore);
- meccanismo patogenetico (scariche ectopiche, perdita del sistema inibitorio, sensibilizzazione periferica e centrale).
La classificazione del dolore neuropatico su base patogenetica appare essere, come confermato da Bonezzi C. et Buonocore M., la più degna di nota perché consente di identificare le vere origini del dolore fornendo, quindi, indicazioni ben precise per l’impostazione del piano terapeutico3. Si distinguono così sindromi di dolore nocicettivo, sindromi di dolore neuropatico e dolore malattia3.
Quali sono i dolori neuropatici?
Il dolore neuropatico viene tradizionalmente classificato in funzione del disordine sottostante5.
Dunque, come abbiamo già anticipato, esiste una prima distinzione, in rapporto alla sede della lesione o malattia a carico del sistema somatosensoriale, in dolore neuropatico centrale o periferico e, all’interno di ciascuna di queste categorie, il dolore viene ulteriormente classificato in relazione alla patologia sottostante5.
Tra i dolori neuropatici centrali si distinguono per esempio5:
- dolore post-ictus;
- lesioni del midollo spinale;
- dolore da sclerosi multipla.
Tra i dolori neuropatici periferici troviamo invece5:
- dolore post-amputazione;
- nevralgia del trigemino;
- radicolopatia (condizione che interessa le radici dei nervi spinali e relativi prolungamenti);
- polineuropatie;
- nevralgia post-erpetica;
- lesioni a carico dei nervi periferici.
Dolore neuropatico sintomi
Chi soffre di dolore neuropatico accusa un dolore spontaneo continuo o intermittente spesso associato a sensazioni dolorose lancinanti e/o brucianti5.
Tra le altre sensazioni maggiormente riferite figurano5:
- allodinia, dolore scatenato da stimoli normalmente innocui e senza conseguenze;
- iperalgesia, risposta amplificata a stimolazioni lievi;
- anestesia dolorosa, dolore spontaneo avvertito in un distretto anatomico anestetizzato;
- disestesia, anomala sensazione del senso tattile accompagnata da dolore, bruciore e prurito;
- iperestesia, eccessiva sensibilità a stimoli tattili, termici e dolorifici;
- iperpatia, sensazione dolorosa anomala dovuta a una stimolazione ripetitiva con coinvolgimento di grandi aree del corpo;
- parestesia, alterazione qualitativa indolore della sensibilità caratterizata da sensazione spontanea di formicolio e/o intorpidimento.
Dolore neuropatico: il nodo della diagnosi
Quando si parla di dolore neuropatico, è doveroso precisare come una semplice “disfunzione” del sistema somatosensoriale non sia sufficiente per poter formulare una diagnosi e questo perché è difficile accettare i sintomi come criteri di inclusione laddove gli stessi non siano obiettivamente verificabili.
Per potere formulare la diagnosi di dolore neuropatico, si deve quindi accertare, come precisato dall’IASP, la presenza di una lesione o malattia a carico del sistema somatosensoriale che soddisfi i criteri di diagnostica neurologica.
La diagnosi di dolore neuropatico appare quindi essere impegnativa anche perché, il dolore neuropatico non è una malattia con una precisa eziologia identificabile e dimostrabile con univocità mediante una valutazione che risponda a criteri di obiettività e riproducibilità.
I criteri diagnostici sono di conseguenza piuttosto labili e le relativamente numerose linee guida diagnostico-terapeutiche sono poco omogenee.
Risultato finale? Un problema diagnostico che influenza non solo l’approccio al singolo paziente, ma anche la confrontabilità tra vari studi clinici e la possibilità che gli stessi possano essere omogeneizzati per revisioni sistematiche.
Bibliografia
- Nuova definizione di Dolore
- Magni A., Aprile Lora P., Ventriglia G., Classificazione e inquadramento del paziente con dolore non oncologico, Rivista Società Italiana di Medicina Generale.
- Bonezzi C., Buonocore M., Aspetti di Fisiopatologia e Terapia del Dolore
- Murnion B. P. (2018). Neuropathic pain: current definition and review of drug treatment. Australian prescriber, 41(3), 60–63.
- Finnerup, N. B., Kuner, R., & Jensen, T. S. (2021). Neuropathic Pain: From Mechanisms to Treatment. Physiological reviews, 101(1), 259–301.